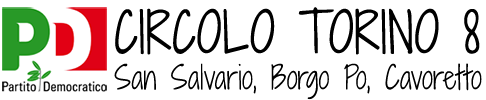CAMBIARE IL MODELLO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE Una proposta provocatoria e innovativa
Questo documento parte dall’analisi della crisi profonda dei modelli capitalistici e socialdemocratici che mostrano limiti ormai evidenti a cui è necessario contrapporre una nuova concezione di organizzazione politica, economica e sociale della società.
Questo è un documento con aspetti anche utopistici e sicuramente fuori dagli schemi dell’attuale dibattito politico.
Siamo partiti dal constatare che tutti i Paesi dell’Europa Occidentale e non solo, mostrano le stesse crisi di sviluppo economico , le stesse, in forme più o meno accentuate, spaccature nelle relazioni sociali , la stessa disaffezione alla politica (bassa conflittualità tra le classi, astensionismo, assenza di “Statisti” etc.), inutile attribuire responsabilità soggettive.
La dinamica sociale della seconda metà del ‘900 si può riassumere come lo scontro tra due sistemi valoriali quello di un “capitalismo liberale” fiducioso nell’autoregolamentazione del mercato e quello di tipo “socialdemocratico” che assegna allo Stato il ruolo riequilibratore delle intollerabili disuguaglianze sociali ed economiche. Scontro portato avanti in un “contesto” di risorse ambientali considerate inesauribili. Senza rifare la storia di un lungo periodo ci limitiamo a mettere in evidenza i profondi cambiamenti avvenuti dagli anni ‘50 ad oggi. Poniamo l’attenzione su un paio di dati che ci servono solo per capire dei macrofenomeni.
| Rapporto Capitalizzazione/PIL nell’area Euro con significative variazioni per Paese | Periodo |
| 8%-15% | Anni ‘50 |
| 60% – 70% | 2023 |
Questi dati ci dicono che pur permanendo in nettissima maggioranza le imprese controllate direttamente dall’imprenditore rispetto alle Public Company, queste ultime hanno notevolmente aumentato l’incidenza rispetto ad occupati e PIL.
Nel dopoguerra
Era dell’Imprenditore.
Il capitalismo che ha caratterizzato gran parte del XX secolo era spesso incentrato sulla figura dell’imprenditore-proprietario. In questo modello, la gestione dell’azienda e la sua proprietà erano strettamente legate.
Fonte di capitale: L’imprenditore si rivolgeva eventualmente al mercato azionario per raccogliere i fondi necessari per i propri progetti di espansione, ricerca e sviluppo. Gli azionisti erano visti più come partner a lungo termine che come semplici speculatori.
Obiettivo: La crescita sostenibile e la creazione di valore a lungo termine erano priorità. L’azienda era vista come un’entità complessa che doveva generare valore non solo per gli azionisti ma, ancorché in una dialettica conflittuale, per i dipendenti, la comunità e i clienti.Ruolo del management: Il consiglio di amministrazione era solitamente composto da individui con una profonda conoscenza del settore e un legame diretto con l’azienda e la sua missione.
Ruolo del management: Il consiglio di amministrazione era solitamente composto da individui con una profonda conoscenza del settore e un legame diretto con l’azienda e la sua missione.
A partire dalla fine del XX secolo
Il Capitalismo Finanziarizzato
Nel nuovo Millennio abbiamo assistito a una trasformazione radicale. Il capitalismo odierno è sempre più dominato da attori finanziari come fondi di investimento, hedge fund e fondi pensione.
Fonte di capitale: Il capitale non viene più raccolto solo per finanziare progetti industriali, ma è spesso utilizzato per operazioni di finanza straordinaria come fusioni, acquisizioni e buyback (il riacquisto di azioni proprie da parte dell’azienda per aumentarne il valore di mercato).
L’obiettivo principale diventa l’aumento del valore delle azioni e la distribuzione di dividendi elevati nel breve periodo. Questo può portare a decisioni che sacrificano investimenti a lungo termine, come la ricerca e lo sviluppo, a favore di un aumento immediato del prezzo delle azioni.
Ruolo del management: Il consiglio di amministrazione non è più scelto per la sua conoscenza del settore, ma per la sua capacità di soddisfare le aspettative dei grandi investitori. A volte, il management riceve un compenso basato sulla performance del titolo in borsa, creando un ulteriore incentivo a dare priorità al breve termine.
Le Conseguenze del Cambiamento
Questa transizione ha avuto effetti profondi sull’economia e sulla società:
Impatto sulla crescita: Le aziende sono meno propense a investire in innovazione e sviluppo a causa della pressione per i risultati trimestrali. Ciò può rallentare la crescita economica complessiva.
Disoccupazione e precariato: La ricerca della massima efficienza finanziaria porta spesso a tagli dei costi, che si traducono in riduzioni di personale, delocalizzazioni e aumento del lavoro precario.
Disparità sociale: Una maggiore enfasi sui dividendi e sul valore delle azioni tende a concentrare la ricchezza nelle mani di chi detiene i titoli, alimentando la disparità tra il l’1% della popolazione più ricca e il resto.
In sintesi, il capitalismo si è evoluto da un modello in cui l’obiettivo principale era la creazione di valore industriale a un altro in cui la priorità è la creazione di valore finanziario.
La Contrattazione nell’Era del Valore Industriale
Nel modello di capitalismo guidato dall’imprenditore, esisteva una sfera di interessi comuni tra il management e i lavoratori. Sebbene le contrapposizioni su salari e condizioni di lavoro fossero inevitabili, entrambe le parti avevano un interesse condiviso nella prosperità dell’azienda.
Punti di mediazione: La negoziazione si basava su un terreno comune. I sindacati potevano chiedere aumenti salariali o migliori condizioni, sapendo che l’imprenditore aveva un incentivo a mantenere una forza lavoro stabile e motivata per garantire la continuità produttiva e l’espansione del mercato.
Ruolo del sindacato: I sindacati, in questo contesto, svolgevano un ruolo di “partner sociale”, non solo di oppositori. Le loro richieste erano spesso orientate al lungo termine, come la formazione professionale o la partecipazione a programmi di welfare aziendale, elementi che contribuivano alla solidità dell’impresa.
La Contrattazione nell’Era del Valore Finanziario
Il passaggio a un’impresa focalizzata sul valore finanziario ha spezzato questo legame. I nuovi proprietari, spesso fondi di investimento, non hanno alcun interesse intrinseco nella crescita industriale a lungo termine dell’azienda o nella sua stabilità sociale. Il loro unico obiettivo è massimizzare i ritorni finanziari per i loro investitori, in tempi brevi.
Assenza di interessi comuni: L’interesse del fondo è aumentare il valore delle azioni, spesso attraverso misure di taglio dei costi, come la riduzione della forza lavoro, la delocalizzazione o la compressione dei salari. I lavoratori, in questo scenario, non sono più visti come un asset da coltivare, ma come un costo da minimizzare.
Riduzione del potere sindacale: Senza un punto di mediazione su cui basare le trattative, i sindacati si trovano in una posizione di estrema debolezza. Le loro richieste di protezione dei posti di lavoro o di investimenti a lungo termine non trovano eco, poiché vanno direttamente contro gli obiettivi finanziari dei proprietari. La minaccia di delocalizzazione o di vendere l’azienda a un’entità che promette maggiore redditività diventa uno strumento di pressione inaffrontabile.Queste le evoluzioni trainate dai valori del “libero mercato”. Esaminiamo quelle ingenerate dal pensiero “socialdemocratico”. Anche qui partiamo da qualche dato.
Rapporto Spesa Pubblica Primaria su PIL
| Nazione | 1951 | 2024 |
| Italia | 22,5% | 46,7% |
| Francia | 25% | 54,5% |
| Germania | 28% | 48% |
Alla spesa pubblica è stato sottratta la Spesa per Interessi sul Debito (2024 stima): Circa il 3,9% del PIL. Almeno per l’Italia andrebbe invece aggiunta la quota del PIL gestita dalle aziende controllate dallo stato (ENI, ENEL, Leonardo….) non inferiore al 10% del fatturato aggregato.
Quindi circa il 60% del PIL è sotto il controllo diretto della gestione pubblica
Possiamo ipotizzare che il modello occidentale europeo caratterizzato da un approccio che vede nello stato l’elemento riequilibrativo in termini di redistribuzione abbia raggiunto negli ultimi decenni del ‘900 il punto di massima efficienza prima che si dispiegassero i limiti di ciò che chiamo gli effetti collaterali.
L’Impatto Globale Delle Inefficienze Statali
L’aumento del rapporto tra Spesa Pubblica Primaria e PIL comune a tutti i Paesi occidentali amplifica il peso delle inefficienze domestiche sull’economia globale per due ragioni principali:
Effetto Moltiplicatore sul PIL
L’aumento del debito pubblico e, di conseguenza: Interdipendenza e Contagio Finanziario
La Distorsione della Classe Politica
L’aumento della Spesa Pubblica Primaria sul PIL in Occidente, passando da circa il 20-30% al 40-55%, ha trasformato la natura stessa del potere politico, rafforzando la tendenza al clientelismo e al rent-seeking (ricerca di rendita)
Attrazione di un Politico “Amministratore”: Il potere si sposta dal legislatore (chi fa le leggi) al gestore (chi alloca fondi e appalti). Questo attrae politici la cui principale motivazione è la possibilità di gestire e indirizzare flussi di spesa (finanziamenti per progetti, assunzioni, sussidi). La competenza richiesta non è più solo quella ideologica o normativa, ma la capacità di negoziare la distribuzione di grandi “premi” pubblici.
Aumento dell’Elettorato di Rendita: L’aumento della spesa crea una vasta “coalizione di beneficiari” o un “elettorato di rendita”. Questo gruppo (che può includere dipendenti pubblici, fornitori dello Stato, o beneficiari di sussidi specifici) è motivato non dal benessere economico generale del Paese, ma dalla necessità di mantenere o espandere i flussi di spesa da cui dipende. Questo spinge il sistema politico a preferire sempre più debito e spesa al posto della crescita economica.
Disaffezione Politica e Scarsa Partecipazione
Aumento dell’Astensionismo: L’astensione aumenta soprattutto tra le fasce di popolazione che si sentono maggiormente svantaggiate o non rappresentate dal dibattito dominato dalla spesa pubblica. Questo fenomeno è spesso più accentuato tra i giovani e i lavoratori precari, che sono chiamati a pagare il conto del debito accumulato, ma che hanno meno potere contrattuale immediato sui flussi di spesa.
Voto di Protesta e Populismo: Quando la politica tradizionale sembra incapace di incidere sulle inefficienze e sul clientelismo, l’elettorato disilluso si sposta verso il voto di protesta o le opzioni populiste/anti-sistema. Questi movimenti non sempre offrono soluzioni strutturali all’inefficienza, ma la loro attrattiva deriva proprio dalla promessa di “rompere” l’establishment percepito come colluso con gli interessi della spesa pubblica.
In definitiva, l’espansione della spesa primaria sul PIL e gli effetti che ne derivano (inefficienze e clientelismo) possono portare a una democrazia in cui la partecipazione civica si polarizza, dove il voto è sempre più uno strumento per accedere a rendite o per esprimere rabbia, piuttosto che per perseguire il bene comune e l’efficienza dello Stato.
Cosa ci ha lasciato la fine del ‘900
Negli Stati Europei le lotte operaie, dopo le due drammatiche guerre mondiali, hanno portato ad assetti politici più o meno socialdemocratici raggiungendo conquiste irreversibili ed essenziali quali: Assistenza Sanitaria Universale, Diritto allo Studio, Sicurezza Pensionistica e Diritti Sociali e Civili. Questo modello ha di fatto raggiunto molti dei suoi obiettivi principali, ma come tutti i modelli mostra i suoi limiti ad ulteriori sviluppi. La sua evoluzione è imprescindibile per non lasciar prevalere, come purtroppo spesso è avvenuto un ritorno al modello atavico basato sulla “legge del più forte”, che come la storia ci ricorda, ha portato all’uso della violenza.
Abbiamo bisogno di un chiaro Modello Valoriale basato sulla Conoscenza, la Fiducia ed il Rispetto per l’Ambiente. I veri Capitali: Umano, Sociale ed Ambientale, ed un Modello di Governance Partecipativa.
Un’evoluzione che ci ricordi sistematicamente questi valori in una dimensione capace di preservare un presupposto essenziale la P.A.C.E. Proviamo a declinare questo splendido acronimo sotto il profilo Politico, Sociale ed Economico.
P come Partecipazione ( Cittadinanza Attiva, Democrazia Deliberativa )
Evoluzione del concetto di Liberté oggi intesa come libertà negativa (assenza di interferenza statale).
La libertà deve trasformarsi in azione attiva e co-responsabile . Il cittadino non è più un destinatario passivo, ma un attore pratico nella co-gestione dei servizi e delle strutture sussidiarie.
Il potere di gestione è distribuito tra Utenti, Lavoratori e Finanziatori. Superamento della Delega: La partecipazione attiva neutralizza la disaffezione civica e l’assunzione di rendita.
A come Ambiente (un vincolo etico-economico non un’opzione politica)
Una preoccupazione non presente nel ‘700. La quantità di risorse ambientali consumate era tale da ripristinarsi naturalmente.
Saggezza Pratica : Le decisioni di governance sono filtrate attraverso l’impatto ecologico a lungo termine.
Investimento Selettivo: Priorità assoluta a spese che garantiscano il ripristino o la sostenibilità delle risorse.
Il pilastro ecologico: Transizione ecologica giusta (Economico). Tutela delle risorse e salute pubblica (Sociale). L’Ambiente come bene comune da tutelare (Politico).
C come Conoscenza (dalla Fraternité quale richiamo emotivo e morale alla solidarietà a lungo termine guidata da competenza, e trasparenza)
La conoscenza condivisa è il fondamento della Fiducia e l’antidoto al populismo
La necessità della competenza per l’efficienza.
Focus sull’Output: La valutazione dell’efficacia sostituisce il controllo burocratico della procedura (meno regole, più risultati).
L’Istruzione e la Ricerca come Motore di Progresso
Fattore abilitante. Diritto universale allo studio e alla formazione continua (Sociale). Investimenti in ricerca e innovazione tecnologica (Economico). Consapevolezza critica per la cittadinanza (Politico).
E come Equità (dalla Égalité formale all’Equità sostanziale)
Equilibrio Strutturale (Equi-): Il principio che garantisce una giusta distribuzione del potere.
Contrasto al Clientelismo: Moltiplicando i centri di decisione (e bilanciando gli interessi), si neutralizza la rendita politica.
Superamento dell’Uguaglianza Formale: Riconoscere le diverse esigenze degli stakeholder per garantire un risultato finale giusto e bilanciato.
Sulla tecnologia ci teniamo a sottolineare che:
le tecnologie sono una risorsa importantissima, ma come tutte le risorse possono essere indifferentemente utilizzate per costruire o per distruggere. Sono i valori, gli obiettivi determinati dal modello di sviluppo che scegliamo di adottare che possono determinare un loro utilizzo di sviluppo e crescita equa o di sopraffazione (vale anche per le più recenti innovazioni, intelligenza artificiale inclusa, certo cambieranno le professionalità richieste, ma se il valore creato dalle innovazioni tecnologiche verrà utilizzato ridistribuendone i vantaggi, verranno generati nuovi bisogni e quindi nasceranno nuove professioni.
Le leve su cui agire nella realtà odierna per intravvedere un Futuro di P.A.C.E.
- Diffondere il Modello Valoriale che poggi sulla Conoscenza, la Fiducia ed il Rispetto per l’Ambiente. Riuscire a far cogliere l’importanza dei Capitali Umano, Sociale ed Ambientale per generare Valore in termine di Benessere Equo e Sostenibile. (il primo allegato al Documento Economico Finanziario riporta gli indicatori del BES e le previsioni di variazione in base ai provvedimenti ipotizzati nel DEF medesimo ma nessuno ne parla)
- Ribilanciare le politiche di sviluppo economico aumentando i consumi interni attraverso aumenti salariali. Diminuire le disuguaglianze, incluso quelle di genere, non è solo un fatto di equità sociale è la via principale per rilanciare lo sviluppo economico.
- Avviare una intensa mobilitazione per una Europa Federale a partire immediatamente dalla trasformazione in senso transnazionale dei corpi intermedi della società. (partiti, sindacati, associazioni no profit)
- Monitorare i risultati delle Società Benefit e gli effetti della Legge 76 sulla partecipazione dei lavoratori per spostare in avanti il loro ruolo nelle aziende. Non dobbiamo diventare tutti azionisti, ma dobbiamo superare la dicotomia tra conflitto e collaborazione. Per uno sviluppo armonico la gestione aziendale deve passare da un modello shareholder ( solo a favore degli azionisti) ad un modello stakeholder (a favore dei soggetti interessati). Non raccomandazioni o linee guida ma passaggio di poteri nella nomina degli amministratori a cominciare dalle società che erogano servizi in concessione e di pubblica utilità. E’ possibile avviare una sperimentazione in una società a controllo pubblico?
- Riavvicinare lavoratori e cittadini alla partecipazione democratica a partire dal vissuto quotidiano: sia sul lavoro, che nella ricerca di soluzioni collettive ai propri problemi, tramite Comunità Energetiche Rinnovabili, l’Abitare Sociale, la condivisione dei mezzi di trasporto, ecc…
- Diffondere la cultura dell’Agenda ONU 2030 monitorando progressi e arretramenti. Riflettendo su cause ed effetti derivanti da ogni iniziativa intrapresa.
- Lavorare in ogni quartiere per attivare e mobilitare tutte le componenti che si sono riconosciute nei Comitati dei Si nell’ultimo referendum e che hanno collaborato sui temi quali salario minimo e Sanità Pubblica.
- “Ultimo ma non per ultimo”, anzi la precondizione affinché il PD possa essere motore trainante di una simile visione, rivitalizzare il ruolo del Partito a partire dai suoi Circoli. Per tornare a generare fiducia nei cittadini è necessario che i Circoli, magari più ricompattati ma più presidiati, e gli organismi di direzione del Partito ai diversi livelli siano sedi attive di confronto per orientare e verificare le necessarie attività di mediazione politica che gli eletti sono chiamati a portare avanti in tutte le Istituzioni in cui operano. Necessaria anche una riflessione del modello organizzativo del Partito che si basa su un modello sostanzialmente invariato rispetto ai partiti novecenteschi di massa del dopoguerra. Di fatto l’impossibilità da parte di volontari di garantire impegno gravoso e costante nel tempo rende poco efficace l’azione politica. Potremmo pensare ad una segreteria politica decisamente più snella che utilizzi gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi definiti sia in ambito territoriale che su tematiche più generali. Tali gruppi di lavoro dovrebbero avere tempi prefissati ed essere costituiti da iscritti con la necessaria disponibilità operativa per il periodo di tempo stimato necessario al raggiungimento dell’obiettivo.
TAVOLO CULTURA ALLARGATO PD 7 e PD8 Torino 13 ottobre 2025
N.B. In questo andamento ci sembra si possano riconoscere le conquiste del welfare, la bolla finanziaria del 2000, la crisi dei subprime, e l’odierno stallo.