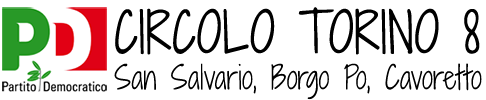Abstract
Il documento propone di ridefinire il concetto di progresso e benessere sociale, spostando la misurazione dal solo capitale monetario-finanziario a tre pilastri vitali: capitale umano, naturale e sociale. L’attuale modello, basato su indicatori economici, ha generato disuguaglianze e sfruttamento delle risorse. Suggeriamo un ritorno al significato originale di “capitale” come “fondamento”, proponendo un “Modello di Valori Vitali” che promuova conoscenza, sostenibilità e cooperazione. Vengono indicati approcci per sviluppare questi capitali, come l’innovazione responsabile e l’inclusione, concludendo con l’importanza di applicare questi concetti nella politica e nella cultura civica, anche attraverso un Partito Europeo per un’Europa più forte.
É una ipotesi di quadro valoriale che potrebbe sembrare scontato all’interno del nostro partito.. Tuttavia riteniamo che alcune delle considerazioni qui esposte non trovino la dovuta attenzione e sottolineatura, esponendoci spesso ad una subalternità culturale del tipo “Business is Business”. Riprenderne con forza la discussione e la definizione, secondo noi, potrebbe aiutarci ad inquadrare le nostre scelte politiche, ad ispirare i nostri amministratori, ai vari livelli, ad agire nella realtà con coerenza, riducendo disorientamento e insicurezza nei nostri elettori ed a riprenderci una nostra pedagogia culturale.
Premessa
Alla base di queste proposte che non costituiscono al momento un documento condiviso nella sua integrità, c’è il lavoro di studio, analisi e confronto avviato nel Gruppo Cultura del Circolo PD8 Giorgina Levi, proseguito negli interforum Lavoro – Istruzione – Sanità – GD Torinesi, ed alimentato dal lavoro congiunto con attivisti del Circolo Miriam Makeba da febbraio a maggio 2025.
Un tentativo di ricercare i Veri Valori Vitali e le linee strategiche per perseguirli
Per molto tempo, abbiamo teso a misurare il progresso e il benessere delle nostre società quasi esclusivamente attraverso lenti economiche e finanziarie.
Il capitale monetario-finanziario ha assunto un ruolo predominante, elevato a metro quasi esclusivo di valore. Questo approccio ha spesso condotto a sistemi che, nella ricerca di una crescita basata su indicatori parziali, hanno finito per sacrificare il benessere delle persone e la salute del pianeta. I risultati sono sotto i nostri occhi: crescenti disuguaglianze, un progressivo esaurimento delle risorse naturali e una fragilità sociale sempre più manifesta.
Ma perché, allora, continuiamo a usare la parola “capitale”? Forse è proprio nella sua etimologia che possiamo trovare una chiave di lettura più profonda. La parola “capitale” deriva dal latino caput, che significa “testa”, ma anche “origine”, “parte principale”, “ciò che sta alla base”, o persino “fondamento”. In tempi antichi, si riferiva al “capitale vivo”, ovvero il bestiame, una ricchezza fondamentale per la sopravvivenza di una comunità. Solo in seguito ha assunto il significato di “somma principale” di denaro.
È forse in questa radice che possiamo riscoprire il nostro intento: utilizzare il termine “capitale” per indicare ciò che è essenziale, ciò che fonda e genera valore reale. Potremmo provare a reindirizzare la sua accezione dall’esclusiva dimensione monetaria verso ciò che costituisce la vera “testa”, la vera “origine” della prosperità e del benessere condivisi. Il capitale finanziario, in questa prospettiva, potrebbe essere meglio inteso come un possibile mezzo, uno strumento per regolare e facilitare le relazioni e gli scambi, e non come un valore assoluto o un fine in sé stesso, ruolo che sembra aver acquisito oggi.
Dovremmo forse riconoscere una verità che è sempre più evidente: i veri pilastri su cui potrebbe costruirsi una società più prospera, giusta e duratura non sono primariamente il denaro e le transazioni finanziarie. Sono piuttosto l’essere umano, la natura e le relazioni che siamo in grado di intessere.

La Dimensione delle Sfide: Disuguaglianze, Depauperamento risorse e Conflitti Globali
La necessità di un cambiamento nei nostri modelli non è una mera speculazione filosofica, ma una questione che tocca la nostra stessa sopravvivenza. Ci troviamo in un’epoca di sfide crescenti, dove il perseguimento non mediato del solo capitale monetario-finanziario sembra spingere il genere umano verso direzioni che potrebbero condurre a un rapido declino. Due dati, tra i tanti, possono aiutarci a percepirne la dimensione e la loro possibile correlazione con la crescente instabilità globale:
- Disuguaglianza Estrema e Potenziali Tensioni Sociali: Secondo il Report Oxfam, l’uno per cento della popolazione mondiale detiene il quarantacinque per cento della ricchezza in termini economici finanziari. Questa concentrazione estrema di potere e risorse potrebbe non essere solo un’ingiustizia, ma un fattore che alimenta tensioni sociali, spinte migratorie e possibili instabilità politiche. La privazione economica e la percezione di mancanza di prospettive creano un terreno fertile per frustrazione e risentimento, talvolta spingendo verso la ricerca di soluzioni che possono apparire estreme, alimentando potenziali conflitti interni e internazionali.
- Esaurimento delle Risorse e Pressioni sui Conflitti: Il Global Footprint Network ci mostra che l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno, si è spostato dal dicembre del 1972 all’agosto del 2024. Questo indica che stiamo consumando le risorse del futuro, mettendo a rischio la possibilità di vita per le generazioni a venire. La scarsità di acqua potabile, la desertificazione, la riduzione dei terreni coltivabili e la competizione per l’accesso alle materie prime non sono solo problemi ambientali; possono diventare tra le cause più profonde e crescenti di criticità geopolitiche e conflitti armati in diverse parti del mondo, rendendo le aree più vulnerabili focolai di instabilità.
Questi esempi non sono isolati. Un’ulteriore dimostrazione di come il perseguimento esclusivo di obiettivi economici non si traduca automaticamente in un miglioramento del benessere la troviamo nel confronto tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Nonostante gli Stati Uniti abbiano registrato una crescita del Prodotto Interno Lordo nettamente superiore rispetto all’Europa in un arco di tempo significativo, i benefici in termini di aspettativa di vita e riduzione delle disuguaglianze non hanno seguito lo stesso andamento.

Come si evince, tra il 1980 ed il 2022, la crescita economica negli USA (+106% di PIL) è stata quasi il doppio di quella Europea (+55%), eppure l’aspettativa di vita media dei cittadini americani è aumentata di soli tre anni, contro gli 8 anni guadagnati dai cittadini dell’UE. Questo divario evidenzia che la crescita del PIL, se non accompagnata da politiche che riducano la diseguaglianza (cresciuta molto di più negli USA che in EU nello stesso periodo) e promuovano il benessere sociale, può risultare uno strumento inefficiente per migliorare la vita della Comunità. La crescita economica, pertanto, non è un fine, ma un mezzo che deve essere orientato a produrre benefici per tutti.
Come:
L’analisi dell’aspettativa di vita, pur focalizzandosi sulla salute, ci offre uno spunto cruciale per riflettere sulle fondamenta della nostra economia. Sebbene il progresso in termini di longevità sia un obiettivo primario, è altrettanto essenziale considerare il modello economico che sottende il benessere delle nostre società. Il rilancio economico post-crisi della globalizzazione non può più basarsi sulle stesse ricette del passato.
La crisi del 2008, ad esempio, è stata affrontata spesso puntando sullo sviluppo dell’export e sulla compressione dei salari. Questa strategia, se da un lato ha permesso a molte economie di riprendersi, dall’altro ha contribuito a polarizzare la ricchezza e a ridurre il potere d’acquisto interno. Oggi, per garantire una crescita sostenibile e inclusiva, è imperativo spostare il focus. Per consentire un nuovo slancio alla nostra economia, dobbiamo puntare sui consumi interni. Ciò implica una chiara necessità di aumentare i salari e stimolare gli investimenti.
Tuttavia, l’aumento indiscriminato dei consumi e degli investimenti non basta. La vera sfida è definire quali consumi e quali investimenti siano prioritari. Qui emerge la necessità di dotarsi di un modello valoriale largamente condiviso, che ponga al centro i Veri Valori Vitali.
E se affrontiamo temi drammaticamente attuali come i sanguinosi conflitti, ora in corso appena a sud ed ad est della nostra Unione Europea? La Pace, infatti, forse non la si persegue efficacemente né con la famosa, ma potenzialmente fuorviante, massima “si vis pacem para bellum” (se vuoi la pace, prepara la guerra), che sembra invece perpetuare un ciclo di violenza, né semplicemente invocandola a gran voce. Una strada concreta e imprescindibile per una pace più duratura potrebbe essere proprio costituita dall’individuazione e dall’adozione di un nuovo, più corretto modello valoriale che riconosca e valorizzi i veri pilastri della nostra esistenza, verso un nuovo ordine multilaterale come primo passo “Per una Costituzione della Terra” (l’utopia di Ferrajoli). Forse è tempo di riconoscere una verità fondamentale: i veri pilastri su cui si potrebbe costruire una società prospera, giusta e duratura non sono il denaro e le transazioni finanziarie fini a sé stesse.
Ne sembrano essere risolte le contraddizioni, nei diversi tentativi di passare da un liberismo ad uno meno sfrenato, o al Capitalismo di stato che continui, comunque sempre, a rincorrere gli stessi obiettivi monetari-finanziari.
Sono piuttosto l’essere umano, la natura e le relazioni che siamo in grado di intessere i Veri Capitali Fondamenti per un Futuro Più Sostenibile
Il Capitale Umano: La Ricchezza delle Conoscenze e delle Competenze
Il capitale umano potrebbe essere inteso come l’insieme delle conoscenze, competenze, abilità e talenti che ciascun individuo può apportare alla comunità. È la capacità di apprendere, creare, innovare e risolvere problemi. Forse, investire nel capitale umano significa garantire a ogni persona l’accesso a un’istruzione di qualità, alla formazione continua e a opportunità di sviluppo personale che ne valorizzino il potenziale unico. Potrebbe essere considerato un motore cruciale per l’innovazione, la cultura e il progresso civile.
Il Capitale Naturale: Rispetto, Sostenibilità e Rigenerazione
Il capitale naturale è la base stessa della nostra esistenza. Comprende tutte le risorse e i sistemi ecologici che ci sostengono: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, la fertilità del suolo, la biodiversità, le foreste, i mari. Oltre al rispetto per la loro essenzialità, come l’acqua per tutte le forme di vita, potrebbe essere imperativo adottare un approccio basato sulla sostenibilità e sulla rigenerazione. Questo potrebbe significare gestire le risorse in modo da non comprometterle per le generazioni future, promuovendo pratiche circolari, energie rinnovabili e la tutela degli ecosistemi.
Il Capitale Sociale: La Forza delle Relazioni e della Fiducia Reciproca
Il capitale sociale è il tessuto connettivo di ogni comunità. Potrebbe manifestarsi nello sviluppo di relazioni interpersonali, nella fiducia reciproca, nell’empatia e nella cooperazione tra i membri della società. È la capacità di lavorare insieme per obiettivi comuni, di sostenersi a vicenda e di costruire reti di solidarietà. Un elevato capitale sociale potrebbe rendere le comunità più resilienti, inclusive e capaci di affrontare sfide collettive.
Gli Approcci per lo Sviluppo dei Veri Capitali
Lo sviluppo e la valorizzazione di questi capitali essenziali potrebbero richiedere un cambio di paradigma profondo, guidato da approcci specifici e interconnessi:
1. Innovazione Responsabile e Accessibile
L’innovazione tecnologica e scientifica potrebbe essere un motore di benessere collettivo, non un privilegio per pochi. L’innovazione responsabile implicherebbe che ogni progresso sia valutato eticamente e orientato a risolvere problemi reali e a migliorare la qualità della vita per tutti. Potrebbe essere accessibile, abbattendo le barriere economiche e digitali, e promuovere soluzioni che favoriscano la sostenibilità e l’inclusione, come una medicina avanzata più accessibile o le tecnologie pulite diffuse.
2. Equità e Inclusione Sociale
Questo modello di sviluppo avrà al centro i principi di equità, parità di genere ed inclusione sociale. Questo significherebbe ridurre attivamente le disuguaglianze economiche, sociali e di opportunità, garantendo che i benefici del progresso siano distribuiti più equamente. Potrebbe significare proteggere i diritti delle fasce più vulnerabili della popolazione, promuovere la diversità e assicurare un accesso più universale a servizi fondamentali come l’istruzione di qualità, l’assistenza sanitaria e la giustizia.
3. Partecipazione Civica e Trasparenza
Un modello robusto potrebbe basarsi sulla partecipazione attiva e informata dei cittadini nelle decisioni che li riguardano. La partecipazione civica non sarebbe solo un diritto, ma una leva per decisioni forse più efficaci e rappresentative. Questa potrebbe rafforzarsi con la trasparenza nell’amministrazione, nella gestione delle risorse e nei processi decisionali, contribuendo a costruire fiducia tra cittadini e istituzioni e a contrastare fenomeni di corruzione o opacità.
4. Resilienza e Adattabilità
In un mondo caratterizzato da incertezze crescenti (crisi climatiche, economiche, sanitarie), potrebbe essere fondamentale sviluppare sistemi intrinsecamente resilienti e adattabili. La resilienza permetterebbe di assorbire gli shock e recuperare più rapidamente, mentre l’adattabilità consentirebbe di modificare strategie e strutture in risposta a nuove sfide. Questo potrebbe tradursi nella diversificazione economica, nello sviluppo di infrastrutture sostenibili e nella promozione di comunità capaci di imparare e evolvere continuamente.
Adottare questi principi potrebbe significare spostare il focus da un’ossessiva accumulazione di capitale finanziario a una visione più olistica e lungimirante, dove il vero benessere di una società si misura nella salute dei suoi cittadini, nella vitalità del suo ambiente e nella forza delle sue connessioni umane. Potrebbe essere un cammino verso un futuro più equilibrato, giusto e sostenibile per tutti.
Tutto ciò può apparire magari anche condivisibile ma lontanissimo dal nostro quotidiano. Proviamo allora a coniugare questi concetti in ciò che ci è più immediatamente vicino: istruzione ,sanità, lavoro.
Si tratta ovviamente di qualche spunto per cercare di cogliere alcune implicazioni.
Queste le motivazioni che normalmente in famiglia o a scuola diamo ai giovani per studiare:
- Prepararsi per un lavoro, per una professione
- Crescita personale, ampliamento orizzonti
- Benefici sociali, contributo alla società
Se ci scostiamo dall’analisi dei soliti dati economici quali PIL, tasso di disoccupazione, ecc.. impariamo che tra i determinanti più importanti dello stato di salute vi è proprio il livello di istruzione. Domandiamoci abbiamo mai dato questa importantissima motivazione agli adolescenti che a volte non ritengono per loro importanti quelle finora raccomandate?
Esistono numerosi studi scientificamente effettuati che dimostrano la stretta correlazione tra il livello di istruzione di una persona ed il suo stato di salute.
Il comune di Torino è una delle nove amministrazioni cittadine italiane che ha aderito all’innovativo ed impegnativo progetto per la neutralità climatica 2030. Stiamo dando il giusto rilievo a questo impegno? O lasciamo che qualche inevitabile disagio porti a bollare questa importante iniziativa politica come frutto di fantasie di intellettuali ecologisti?
Abbiamo chiaro che le aziende coinvolte in questi progetti tendono a spostare il punto di forza competitivo dai bassi salari, all’innovazione tecnologica ed organizzativa?
Conosciamo il report dell’ARPA piemontese che attribuisce l’abbassamento di 2 anni dell’aspettativa di vita in Torino a causa delle polveri sottili?
Quanto è forte in questo momento la domanda circa le implicazioni delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, ci sarà ancora il mio lavoro? E se ci sarà come cambierà?
E’ assurdo che solo il 10% della forza lavoro in Piemonte sia coinvolto in attività di formazione permanente. Come mai in una realtà come la BCE sicuramente tra le più sviluppate dal punto di vista del capitale umano, abbia recentemente adottato un dettagliato piano che preveda di incoraggiare il cambiamento di ruolo dei propri dipendenti?
Non dobbiamo aspettare l’espulsione dei lavoratori da una azienda per occuparci della loro riconversione.
Potremmo continuare all’infinito ma non è questo l’obiettivo, quanti di noi conoscono il lavoro non solo dell’ISTAT, ma anche dei qualificatissimi tecnici del Ministero dell’Economia e della Finanza sui parametri del BES? Certo non sono la panacea di tutti i problemi ma le scelte vengono fatte sulla base di ciò che misuriamo. L’allegato n.1 alla legge di bilancio che deve essere inviata alla Commissione Europea contiene l’impatto delle scelte del governo sui parametri del BES. Nessuno di noi le valuta!
Anche nel modo di organizzare la nostra attività politica è opportuno riflettere su come possiamo innovarla, può apparire irrituale preoccuparsi di concordare quali parametri e come rilevarli piuttosto che individuare un programma puntuale da perseguire. In un periodo caratterizzato da profonde e repentine trasformazioni di diversa natura è molto meglio definire senza ambiguità i valori che ci accomunano piuttosto che tutto ciò che vorremmo realizzare. Forse l’uso di una parafrasi di origine matematica può aiutarci a capire meglio. Meglio ricercare il minimo comune multiplo (mcm) piuttosto che il massimo comune divisore (MCD).
Definire cosa e come si misura consente di individuare esattamente il quadrante entro cui ci si vuol muovere lasciando un margine di competizione non conflittuale alle diverse sensibilità politiche nell’ambito di una coalizione.
Nel Partito Democratico sta emergendo con chiarezza un nuovo modello valoriale che, come naturale, porta alla definizione di nuovi paradigmi economici. Ritroviamo, anche se con sfumature diverse, concetti molto vicini a quanto emerso in questo nostro lavoro nel “Manifesto per un’altra Economia e un’altra Politica “ di Emanuele Felice, nei lavori preparatori ed in molti interventi della Conferenza Nazionale sulle politiche industriali “Le Rotte del Futuro “. Sul piano dell’attualità politica, assistiamo a due timori principali:
* La riluttanza a proporre una riforma fiscale che permetta una ridistribuzione della ricchezza tramite politiche attive, capaci di “correggere le disuguaglianze a monte” (come suggerito da Felice).
* La preoccupazione per una potenziale alleanza a livello europeo tra il PPE e le destre ECR, e non solo.
Questi timori ci spingono verso strategie compromissorie al ribasso, che di fatto indeboliscono l’eurozona e minano la fiducia nelle istituzioni europee.
L’Urgenza di un Impegno Culturale e la Visione a Lungo Termine
È fondamentale intensificare il nostro impegno culturale. Ogni azione deve essere coerente con la nostra visione valoriale, anche quando si accettano compromessi come “mali minori” dettati dalla contingenza.
Per una rappresentazione più accurata della realtà e degli obiettivi, è necessario fare riferimento sistematicamente ai parametri del BES (Benessere Equo e Sostenibile) e dell’Agenda ONU 2030. Su questo fronte, è cruciale uno sforzo collettivo affinché tale approccio diventi una consuetudine anche tra giornalisti e opinionisti del mainstream.
Come diffondere queste innovazioni nella prassi politica e nella cultura dei cittadini?
Indubbiamente il fulcro centrale deve essere individuato nei Circoli del nostro partito, sedi non solo di divulgazione ma di confronto ed elaborazione, con flussi informativi e di proposte da e per le segreterie provinciali e gli amministratori locali. I Circoli devono essere come cellule di osmosi tra le diverse forme associative presenti sul territorio ed anche come soggetto promotore di nuove forme di partecipazione democratica dei cittadini (come per esempio, le Comunità Energetiche Rinnovabili).
Ecco la necessità di sostituire il ruolo trainante delle correnti organizzate di fatto intorno agli eletti con un lavoro di squadra dove i diversi ruoli abbiano entrambi piena dignità la continua elaborazione e diffusione culturale delle strutture di partito e l’importante lavoro degli eletti che devono mediare, non solo con gli eletti degli altri partiti, ma con la necessità di ricercare il consenso dei cittadini per quello che in quel momento esprimono.
In questi giorni drammatici per il Medio Oriente sui siti del PSE e su quello S&D è sconfortante l’assenza di una voce di un orientamento. Le soluzioni dei problemi dei cittadini europei devono essere ricercate soprattutto a livello europeo, è quindi necessario che il Partito abbia una struttura a livello transnazionale.
Un Partito Europeo per un’Europa più politica, con maggiori competenze e prerogative, in grado di affrontare anche i problemi nel nostro mondo globalizzato e della Terra interconnessa, un’Europa forte, pacifica, libera, democratica e in grado di difendere un impianto valoriale chiaro per tutti, per la difesa dei diritti, della tolleranza, le libertà, l’inclusione, la separazione dei poteri e lo stato sociale”.
Del resto è ora che l’obiettivo della costituzione di uno stato Europeo Federale sia perseguito con impegno a partire dalla costituzione di un vero Partito Europeo che svolga appieno le funzioni fondamentali di un Partito Democratico Progressista: Elaborare una Visione, creare la classe dirigente.

Torino 21 Luglio 2025
Tavolo Cultura allargato Circoli PD7 e PD8